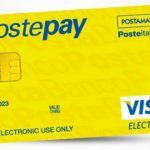Distribuzione del reddito e crescita economia: vecchie e nuove teorie
- Teorie della crescita e distribuzione del reddito
- Crescita economica nelle economie capitalistiche
- Capitale e produzione delle merci
- Lotte operaie, l’individuo è sovrano
- Critica gramsciana all’economia neoclassica
«Innanzitutto conviene di fissare per quanto è possibile la relativa Economica di ciascuna epoca, per spiegare specificamente le classi che in quella si svilupparono, non astraendo da dati ipotetici od incerti, e non generalizzando le nostre condizioni per estenderle a quelle di ogni tempo».
Antonio Labriola, In memoria del Manifesto dei Comunisti.
Qual è lo stato della scienza economica all’alba del terzo millennio? Esiste o no concordanza di vedute sul suo oggetto e sui suoi metodi di analisi? Esiste o no un paradigma teorico accettato dalla comunità degli economisti o, almeno, dalla sua maggior parte? E se sì, qual è? E perché è proprio quello e non un altro?
Un buon punto di partenza per provare a rispondere a queste domande è costituito da due saggi ospitati sul n. 210 (giugno 2000) della rivista “Moneta e Credito“. Ne sono autori due fra i più eminenti economisti viventi, Robert Solow (premio Nobel nel 1987) e Luigi Pasinetti, e l’oggetto del loro contendere – vale a dire la teoria neoclassica della crescita e della distribuzione del reddito -, ancorché circoscritto rispetto alla congerie di problemi con cui si cimentano gli economisti, si presta comunque, specie per l’ampiezza e la profondità con cui essi lo affrontano, a qualche considerazione di carattere generale sull’evoluzione e sullo stato attuale della scienza economica. Questione non già astratta, ma sommamente concreta, visto che, come notava già un secolo fa Alfred Marshall, l’economia indica alla politica “non soltanto quale debba essere lo scopo, ma anche quali siano i migliori metodi atti a raggiungerlo“.
In quanto segue, dunque, mi avvarrò delle ricostruzioni di Solow e, specialmente, di Pasinetti, inscrivendole, però, in una diversa chiave di lettura, volta a mettere in rilievo il legame esistente tra l’avvicendarsi delle teorie economiche della crescita e della distribuzione e l’evoluzione storica delle formazioni sociali dell’Occidente avanzato.
Se è vero che l’economia è “la dottrina della struttura della società borghese“, come diceva il vecchio Labriola, far emergere il nesso fra le trasformazioni dell’una e i cambiamenti dell’altra può offrire, credo, una base più solida al tentativo di rispondere alle domande poste in apertura di queste note.
Teorie della crescita e distribuzione del reddito
Smith e Ricardo, i ‘classici‘ per eccellenza, si possono considerare, rispettivamente, all’origine della teoria della crescita e della teoria della distribuzione del reddito: mentre il primo si occupa della natura e delle cause della ricchezza delle nazioni, individuando nella divisione del lavoro e nell’espansione del mercato il principale modo per accrescerla, il secondo considera oggetto dell’economia politica la determinazione delle leggi che regolano la distribuzione della ricchezza fra le tre grandi classi che prendono parte al processo produttivo: proprietari fondiari, salariati e capitalisti.
In questa fase, che possiamo convenzionalmente datare dal 1776 al 1821, la terra e il lavoro umano sono le principali fonti dei valori d’uso, mentre il capitalista si presenta perlopiù come ‘organizzatore’ dei fattori produttivi originari: del tutto coerente, pertanto, ritenere che il profitto sia un ‘residuo’, cioè quella parte del prodotto netto che resta al capitalista dopo aver pagato la rendita e i salari (questi ultimi supposti al livello di sussistenza storicamente dato).
Mano a mano che procede la ‘sussunzione reale’ del lavoro (e della terra) al capitale, vale a dire mano a mano che il processo produttivo diventa processo meccanizzato, frutto dell’impiego tecnologico della scienza, cambia però anche la sua percezione (e la sua rappresentazione) da parte della teoria economica. Il ponte fra l’una e l’altra versione, come spiega Pasinetti, lo dà la variante ‘intensiva’ della teoria ricardiana della rendita, combinata con la legge dei rendimenti decrescenti.
Senza entrare in dettagli tecnici, basterà ricordare che la rendita di un appezzamento di terreno può essere accresciuta, in termini assoluti, aumentando le dosi ivi impiegate degli altri due fattori della produzione (lavoro e capitale); tuttavia, combinandosi quantità crescenti di questi ultimi con una quantità fissa di terra, i (maggiori) rendimenti dovuti all’impiego di ciascuna dose aggiuntiva (o ‘marginale’) saranno decrescenti fino al limite di zero.
Profitto e capitale
Ora, sul finire del secolo XIX, si verifica la convergenza simultanea di più ricerche indipendenti, maturate in aree geografiche differenti, verso un medesimo risultato, vale a dire la ‘generalizzazione’ del principio ricardiano dei rendimenti decrescenti a tutti i fattori della produzione (lavoro, capitale e terra).
Tra i protagonisti di questa vera e propria rifondazione teorica della scienza economica (definita, perciò, ‘neoclassica‘) sono il francese Walras, l’inglese Jevons, l’austriaco Menger e lo svedese Wicksell, grazie ai quali anche il profitto (o meglio, l’ ‘interesse’) lascia il limbo di reddito residuale (ciò che nel frattempo, complice un certo Karl Marx, aveva dato luogo a dure lotte da parte del movimento operaio per appropriarsene, almeno parzialmente), per assurgere a reddito proprio di uno specifico fattore della produzione, il ‘capitale‘, per il quale – si dice – valgono le medesime leggi distributive vigenti per gli altri due fattori.
Più in particolare, secondo il verbo propalato da quella che, a buon diritto, si può considerare la nuova Bibbia degli economisti, gli Elementi di economia politica pura di Léon Walras (la cui quarta e definitiva edizione appare nell’ottobre del 1900), data una qualunque dotazione iniziale di lavoro, capitale e terra, il processo concorrenziale conduce a prezzi (e quindi a redditi) dei fattori tali che il prodotto ottenuto da ciascuno di essi sia il massimo possibile e che ciascuno di essi percepisca esattamente il suo ‘prodotto marginale‘, senza alcun residuo positivo o negativo (e infatti, dirà Walras, l’imprenditore si presenta faisant ni bénéfice ni perte, senza guadagni né perdite).
Vilfredo Pareto consacrerà questo ‘equilibrio economico generale’ con l’appellativo ‘ottimo‘, a significare così l’impossibilità di migliorare la posizione di qualcuno senza contemporaneamente peggiorare quella di qualcun altro: potente baluardo per ogni forma di rivendicazione sindacalmente organizzata dei lavoratori.
Crescita economica nelle economie capitalistiche
Nel frattempo, la teoria della crescita ristagnava, al pari, del resto, delle economie capitalistiche (siamo all’incirca all’epoca della lunga depressione che chiude il secolo XIX). Fu solo la ripresa dell’economia mondiale, dopo il 1945, a ‘determinarne’ (s’intende, in ultima istanza) la rinascita, che, ovviamente, avvenne all’insegna del ‘principio marginale’.
Era successo, nel frattempo, che, in un articolo del 1939, Roy Harrod aveva dimostrato che una crescita economica continua e in equilibrio dinamico avrebbe potuto aversi soltanto qualora il tasso di crescita del sistema economico fosse stato eguale al rapporto tra risparmio e accumulazione, e ne erano venute accese dispute (specie alla luce della Teoria generale di Keynes) su quale di queste tre grandezze dovesse considerarsi incognita, derivandosene implicazioni assai critiche sulla possibilità di estendere ad una economia non stazionaria la teoria neoclassica della distribuzione del reddito.
Un articolo di Robert Solow, apparso nel 1956 sul “Quarterly Journal of Economics“, sembrò, tuttavia, chiudere ogni discussione in favore dell’ortodossia. Come? È presto detto. Intorno agli anni Venti, specialmente negli Stati Uniti, si era cercato di elaborare degli strumenti operativi capaci di verificare empiricamente la teoria neoclassica e, tra questi, aveva riscosso particolare successo quello (messo a punto nel 1928 da C.W. Cobb e P.H. Douglas) di ‘funzione della produzione‘, intendendosi così la relazione tecnica che esprime la quantità massima di prodotto ottenibile da ciascun insieme di dati fattori produttivi per un dato stato della conoscenza tecnica.
Ora, caratteristica della ‘funzione di Cobb-Douglas‘ era quella di eguagliare i prezzi dei due fattori della produzione considerati (supponiamo, capitale e lavoro) al loro prodotto marginale, in perfetta armonia con l’insegnamento neoclassico: qualora uno dei due fattori avesse richiesto per la propria remunerazione un prezzo più elevato, sarebbe stato prontamente ‘sostituito’ con una dose aumentata dell’altro.
Bene, il succo dell’articolo di Solow stava proprio nella combinazione del modello di crescita di Harrod con l’impiego di una ‘funzione della produzione‘, supposta esistente nei fattori capitale e lavoro: per tal via, date le infinite possibilità di ‘sostituzione’ reciproca dei fattori produttivi, si dimostrava che la crescita economica in equilibrio di piena occupazione era senz’altro possibile con qualunque dotazione iniziale dei fattori stessi, purché fossero mantenute le quote distributive assegnate dal processo concorrenziale.
Capitale e produzione delle merci
L’innesto della teoria della crescita sul tronco della teoria della distribuzione sembrava aver reso la dottrina marginalista inattaccabile. Sennonché, negli anni Sessanta si apre una fase di profondo ripensamento teorico. Via via che il movimento operaio acquista forza e consapevolezza di sé e che l’intervento sempre crescente dello Stato nel processo produttivo si incarica di assicurare non solo la piena occupazione della forza-lavoro disponibile, ma soprattutto un miglioramento generalizzato del tenore di vita, si comincia a indagare più a fondo sulla plausibilità dell’idea neoclassica del ‘capitale’ come fattore della produzione.
Il problema teorico di fondo è dato dal fatto che, mentre la terra e il lavoro sono misurabili in termini fisici e in termini fisici può essere espressa la loro remunerazione, il capitale no: deve essere espresso in termini fisici quando lo si considera come fattore produttivo, ma la sua remunerazione, il saggio del profitto, deve essere espressa in termini di valore, cioè di prezzo moltiplicato per la quantità, e questo ‘prezzo’ a sua volta dipende dal saggio del profitto.
L’impiego della funzione della produzione consentiva di eludere il problema, perché si operava con un modello in cui era prodotta una sola merce, sicché quantità fisica e valore venivano a coincidere; ma non appena si provò a estenderne le conclusioni ad un modello a due o più merci, si vide chiaramente (e anche Wicksell, come ricorda Pasinetti, se ne era accorto) che, salvo casi pressoché irrilevanti, non esisteva alcuna precisa relazione fra saggio del profitto e prodotto marginale del ‘capitale’.
Era sicuramente un brutto colpo per una dottrina che aveva costruito la propria coerenza logica sulla stretta corrispondenza tra l’apporto produttivo e la remunerazione di ciascun fattore della produzione. Ancora più brutto, tuttavia, si rivelò il colpo sferrato dal dibattito sul cosiddetto ‘ritorno delle tecniche’, originato dall’ultimo, seminascosto capitolo di Produzione di merci a mezzo di merci (1960) di Piero Sraffa.
Produzione e salario
Tra le implicazioni più importanti della costruzione neoclassica vi era quella relativa all’esistenza di una relazione inversa fra la quantità impiegata di un certo fattore produttivo e la sua remunerazione: ad esempio, aumentando i salari rispetto ai profitti, la teoria ‘prevedeva’ combinazioni produttive più ‘capitalistiche’; specularmente, qualora i profitti fossero aumentati relativamente ai salari, si sarebbero avute combinazioni produttive con meno capitale e più lavoro.
Sraffa dimostrò che ciò non era vero e che, in generale, non esisteva alcuna connessione necessaria tra la direzione dei cambiamenti del saggio di profitto e la direzione dei cambiamenti nella quantità di capitale per lavoratore. Ne venne un acceso dibattito tra le ‘due Cambridge‘ (quella inglese e quella americana), cui presero parte Joan Robinson, Paul Samuelson, David Levhari, Pierangelo Garegnani, lo stesso Pasinetti e altri, al termine del quale pareva che della teoria neoclassica della distribuzione fossero rimasti solo cocci inservibili e che tutto fosse pronto per la ‘ripresa dell’economia politica classica‘, come Claudio Napoleoni aveva annunciato a conclusione del suo Pensiero economico del ‘900 (1963).
Lotte operaie, l’individuo è sovrano
Invece, accadde dell’altro. ‘Sorprendentemente‘, secondo Pasinetti, ma si badi alle date: il dibattito sul ‘ritorno delle tecniche’ si conclude alla fine degli anni Sessanta, che vedono l’acme delle lotte del movimento operaio; da quel momento in poi, il conflitto di classe declina rapidamente, fino a cedere il passo alla restaurazione thatcher-reaganiana degli anni Ottanta.
Ed è proprio del 1982 un articolo di Frank H. Hahn, dal titolo (vagamente sfottente) The Neo-Ricardians, nel quale si enuncia una tesi strabiliante: le critiche del ventennio precedente si riferiscono soltanto al modello teorico neoclassico inteso in termini aggregati; non valgono, invece, se riferite al modello di equilibrio economico generale inteso in termini disaggregati e fondato su comportamenti di massimizzazione di funzioni individuali inter-temporali di profitto e di utilità, quale era stato nel frattempo elaborato da Kenneth Arrow e Gérard Debreu.
Sarà pure una tesi infondata (lo ha argomentato, tra gli altri, Pierangelo Garegnani), ma ha l’indubbio pregio di sposarsi felicemente con il (nuovo) senso comune. La fine degli anni Sessanta non vede soltanto l’esplosione delle lotte operaie, ma anche l’affacciarsi sulla ribalta sociale e politica dei baby-boomers : più scolarizzati, più informati, più urbanizzati, soprattutto insofferenti verso le gerarchie tradizionali (anche quelle vigenti nelle organizzazioni della classe operaia, partiti e sindacati).
Evocando Nietzsche, come ha fatto Alain Ehrenberg nel suo La fatica di essere se stessi (Einaudi, 1999), si potrebbe dire che l’ ‘individuo sovrano, l’individuo eguale soltanto a se stesso‘ fa per la prima volta la sua comparsa sulla scena.
L’aumento del benessere, seguito alle politiche del welfare, ha reso in larga parte indipendente dall’appartenenza di classe l’accesso a certi consumi (istruzione, sanità, abitazione); la ristrutturazione capitalistica ha ridotto drasticamente il numero degli operai addetti al ciclo produttivo; l’espansione delle spese statali ha comportato l’aumento in termini assoluti e relativi delle ‘classi medie’, cioè della piccola borghesia, assai più sensibile ad un progetto di miglioramento individuale che ad uno di miglioramento collettivo o di categoria (si ricordino le conclusioni di Sylos Labini nel suo Saggio sulle classi sociali o quelle di Pizzorno ne I soggetti del pluralismo); si fa quindi strada l’idea che lo stesso concetto di ‘classe‘ sia stato reso superfluo dal progresso storico.
La scomparsa delle classi dal linguaggio politico e sociale degli anni Ottanta rappresenta, in effetti, la principale ‘anomalia’, direbbe Kuhn, rispetto all’auspicata ripresa della teoria classica della distribuzione e, per contro, lo stimolo più efficace per suscitare l’interesse dei giovani economisti nei confronti del paradigma neoclassico.
Quest’ultimo, infatti, riduce tutti i problemi economici ad uno solo: trovare quel sistema dei prezzi che, tenendo conto delle preferenze individuali degli agenti economici e della distribuzione data delle dotazioni esistenti, conduca all’allocazione ottima delle risorse disponibili.
Sembra un modello di puro scambio, ma – associando a ciascuna risorsa un indice di quantità e un indice di tempo – si può reinterpretarlo in termini inter-temporali: in ogni momento, i postulati di massimizzazione di utilità e di profitto degli agenti (consumatori e imprenditori) conducono il sistema in posizioni di equilibrio temporaneo, contraddistinte da un particolare insieme di prezzi di ogni risorsa, presente e futura. (La produzione, nota a margine Pasinetti, diventa un fenomeno di scambio nel tempo.)
Nuova teoria della crescita economica
È su tali presupposti che viene costruita la ‘nuova‘ teoria della crescita. Sulla scorta di un modello elaborato nel 1928 da Frank Ramsey (un esercizio logico volto a far emergere le proprietà analitiche di un sistema economico ipotetico, in cui un programmatore centrale onnisciente e immortale decide della distribuzione nel tempo della produzione e dei consumi), gli eleganti modelli elaborati negli anni Ottanta e Novanta si riducono ad analizzare il comportamento di un individuo ‘rappresentativo’, non più programmatore per tutti, ma solo per se stesso.
E diventa un nonsenso perfino parlare di distribuzione del reddito: non solo è lo stesso individuo che può decidere se partecipare alla produzione come lavoratore o come imprenditore e percepire salari o profitti, ma per di più questa scelta può variare nel tempo, sempre e soltanto in funzione della massimizzazione delle sue preferenze. Salariato nella maturità, rentier nella vecchiaia: è la filosofia implicita nei fondi pensione.
Critica gramsciana all’economia neoclassica
Certo, l’eleganza della costruzione neoclassica si scontra con parecchie anomalie, teoriche e soprattutto empiriche: Pasinetti vi si sofferma diffusamente, segnalando (d’accordo, qui, con Solow) che la maggiore è, probabilmente, proprio quella di aver lasciato in disparte la questione della distribuzione del reddito, che assume una rilevanza dirompente non appena si considerino le enormi diseguaglianze che si accompagnano alla diffusione del progresso tecnologico.
E lascia intendere che il filone ‘classico‘ di ricerca – quello associato ai nomi di Kalecki, Kaldor, Keynes e Sraffa – potrebbe costituire una cospicua riserva, idonea a sviluppare indagini più pregnanti circa il complessivo assetto istituzionale di un sistema economico in evoluzione (lo stesso Pasinetti è autore di uno dei contributi più interessanti in questa direzione: si veda il suo Dinamica strutturale e sviluppo economico, apparso nel 1981 e, in traduzione italiana, nel 1984).
C’è, però, da considerare che l’insuccesso della ‘scienza normale’ nella spiegazione di un’anomalia non basta per dar luogo ad un mutamento di paradigma: per intendere la stessa rivoluzione copernicana, spiegava ad esempio Kuhn, “dovrebbe essere presa in considerazione anche la pressione sociale per una riforma del calendario“.
Ed è proprio qui che, se si ritiene plausibile la chiave di lettura che ho suggerito, sta il problema. Proverei ad esprimerlo in forma di domanda: se anche coloro che rifiutano le conclusioni del paradigma dominante (e i suggerimenti che ne vengono per la politica, riassumibili nell’antica esortazione del mercante Legendre: nous laissez faire) si attardano ad elogiare la ‘diversità’ e l’ ‘unicità’ di ogni individuo, dimenticando che, sulla base dei rapporti di produzione dominanti, questa ‘unicità’ si pone sullo stesso piano “di una qualità che egli ha in comune con qualsiasi pidocchio e con qualsiasi granello di sabbia” (cito dall’Ideologia tedesca di Marx e Engels), potrà mai farsi luogo, per dirla con Gramsci, ad un qualche
“lavorio di critica, di penetrazione culturale, di permeazione di idee attraverso aggregati di uomini […] refrattari e solo pensosi di risolvere giorno per giorno, ora per ora, il proprio problema economico e politico per se stessi, senza legami di solidarietà con gli altri che si trovano nelle stesse condizioni“? E senza un siffatto “processo molecolare, minutissimo, di analisi estrema, capillare, la cui documentazione è costituita da una quantità sterminata di libri, di opuscoli, di articoli di rivista e di giornale, di conversazioni e dibattiti a voce che si ripetono infinite volte e che nel loro insieme gigantesco rappresentano questo lavorio“, potrà mai nascere una “volontà collettiva di un certo grado di omogeneità, di quel certo grado che è necessario e sufficiente” per conferire senso, prima ancora che vigore, ad una nuova ‘critica’ dell’economia neoclassica?
Purtroppo, è lecito dubitarne.